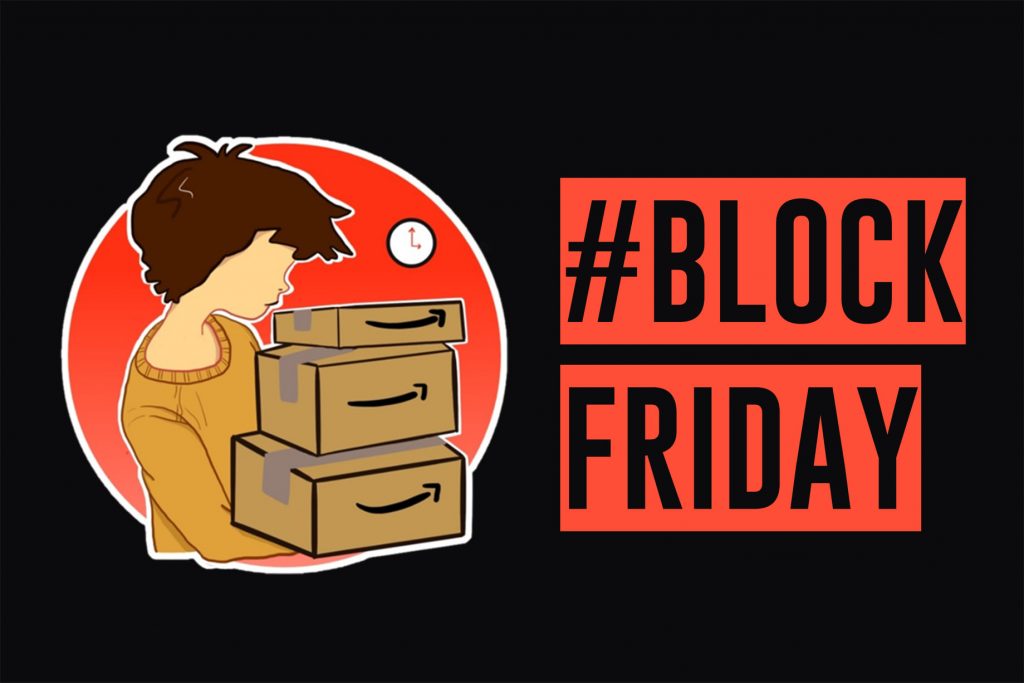Piccola rassegna per riflettere sulle Tecnologie Solidali

Piccola rassegna per riflettere sulle Tecnologie Solidali
Vi proponiamo una piccola rassegna di contributi, secondo noi necessari per riflettere sulla crisi che stiamo vivendo: ogni settimana cerchiamo di rintracciare, all’interno del caos informazionale che ci sommerge, un filo rosso per permetterci di capire la stessa crisi.
Le parole chiave di questa settimana sono: tecnologia, dati, responsabilità e solidarietà.
Abbiamo deciso di parlare di tecnologie e dati perché – e non solo in questo periodo – fanno emergere questioni controverse. La tecnologia non è separabile dal contesto sociale che ne permette messa in forma, sviluppo e innovazione. La tecnologia è, oggi come ieri, uno spazio per riflettere sulla società.
Questa riflessione però non va interpretata in maniera moralista, come se ci fosse una lezione da imparare o un’opportunità filosofica da non lasciarsi scappare. Questa situazione deve essere, secondo noi, occasione di – nel senso di possibilità, di circostanza, di momento adatto per – riflettere su come siamo arrivati fin qui.
Ci sono infatti una serie di condizioni – specificatamente culturali, politiche, sociali – che si manifestano intorno al dilagare del virus. E queste condizioni – o forse contraddizioni – stanno venendo fuori.
Non che tutto questo sia qualcosa di positivo, non fraintendiamoci. In quello che sta succedendo, in questa crisi, non c’è niente di positivo. Si sta rendendo però visibile qualcosa che prima non riuscivamo a vedere. Qualcosa che non riuscivamo più a vedere. Ed è quanto mai necessario cercare di anticipare le conseguenze che verranno.
Vi proponiamo quindi un esercizio. Provate a seguirci tra filosofia, antropologia, sociologia e geopolitica. Provate a rintracciare con noi quelle quattro parole chiave, e perché sia necessario contestualizzarle.
Nota bene: la piccola rassegna che segue è assolutamente arbitraria. Non ci sono legami di necessità tra gli articoli che abbiamo scelto, e i salti tra uno e l’altro potranno apparire lunghi, brevi, azzeccati, banali, inventati o immotivati. Autrici e autori degli interventi citati non hanno preso parte del processo di scrittura, e potrebbero essere completamente in disaccordo con quello che scriviamo. Vi chiediamo la fiducia di seguirci in questo percorso.
1) Sulla fine del capitalismo
Riprendiamo quindi da dove abbiamo lasciato. Avevamo chiuso l’ultima rassegna con una citazione di Bruno Latour. Settimana scorsa, lo studioso di scienza, società e tecnologia ha pubblicato su AOC un appello che non possiamo che condividere. Neanche a farlo apposta le sue posizioni sono perfettamente in linea con quelle tracciate nella nostra precedente rassegna: Latour invita a pensarci come “Interruttori di globalizzazione”, incitandoci a non rinunciare alla fine di quel modello produttivo che stava mettendo in ginocchio il pianeta.
Traduzione nostra: “Non si tratta più di riorientare un sistema di produzione, ma di uscire dalla produzione come principio unico di rapporto con il mondo. Non si tratta di rivoluzione ma di dissoluzione, pixel dopo pixel. Come mostra Pierre Charbonnier, dopo cent’anni di socialismo limitato alla sola redistribuzione dei beni dell’economia, sarebbe forse tempo di inventare un socialismo che contesti lo stesso concetto di produzione. Si tratta di riconoscere che l’ingiustizia non è limitata nell’ambito della redistribuzione dei frutti del progresso, ma è insita nel nostro modo di far fruttare il pianeta. Ciò non vuol dire decrescere, o vivere d’amore o di acqua fresca, ma imparare a selezionare ogni segmento di questo famoso sistema pretenziosamente irreversibile, di mettere in causa ognuna delle connessioni che si dicevano indispensabili, e di dimostrarci (di vicino in vicino) ciò che è desiderabile e ciò che ha smesso di esserlo.” L’articolo si conclude con esercizi di “autodescrizione” che ci permettano di mettere per iscritto che cosa, nella rete mondiale di attori sociali di cui facciamo parte, ci aspettiamo che succeda.
È un esercizio che compie, forse inconsapevolmente, l’economista Paul Mason su Al Jazeera quando si chiede se il coronavirus segnerà effettivamente la fine del capitalismo. Secondo Mason, la crisi del Covid-19 ha portato nell’immediato presente le conseguenze disastrose che il modello produttivo capitalista avrebbe distribuito sul lungo periodo.
Mentre vi invitiamo a leggere la sua analisi sulla necessità di prevedere queste conseguenze attraverso manovre attive, proviamo di seguito a presentarvi la nostra interpretazione. Se le ragioni del capitalismo hanno sempre avuto il potere di tacciare le ragioni sociali, oggi queste stesse non solo si fanno sentire: stanno urlando a gran voce. Siamo di fronte al palesarsi di problematiche sociali e all’estrema urgenza di affrontarle.
E questo non vale solo per l’economia. In tutti i settori della vita sociale, la crisi che accompagna il Covid-19 sta facendo emergere l’insostenibilità dei modelli cui eravamo abituate e abituati. Le soluzioni che stanno venendo proposte, purtroppo, riflettono una mentalità che è la stessa ad averci portato alla crisi, in tutti i settori. Se insistiamo sul superamento di concetti inscritti nei modi di produzione capitalisti è perché gli stessi sono i correlati di un’ideologia, di un modo di concepire problemi e soluzioni.
2) Di dati, privacy e salute
Durante la scorsa settimana si è infiammato il dibattito sulle possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per il controllo dei contagi. Le diverse strategie – tecniche e non solo – messe in atto dai diversi paesi per ricostruire – o prevenire – la diffusione del virus sollevano innumerevoli questioni di carattere biopolitico, etico e sociologico.
All’interno del dibattito sulla cessione dei dati a compagnie private o a enti pubblici, Bruno Saetta su Valigia Blu illustra perfettamente la distinzione dalla quale intendiamo partire, cioè le soluzioni previste per l’Europa e quelle messe in atto in Oriente (grassetti nostri): “Un’idea circolata è che si potrebbero utilizzare i dati dei gestori di telefonia (Telecom) e delle grandi piattaforme del web (Google, Facebook). Nella Corea del Sud e a Singapore, invece, si è preferito coinvolgere il meno possibile i privati. Il privato agisce per profitto, per cui una volta coinvolto (oltre alla moltiplicazione dei rischi dovuti alla moltiplicazione degli attori coinvolti), diventa difficile dire al privato di chiudere tutto il suo lavoro alla fine dell’emergenza. Il pubblico, invece, può operare anche in perdita, e quindi può (e dovrebbe essere ben chiaro nella legge istitutiva della misura) decidere di cancellare tutti i dati raccolti alla fine dell’emergenza. Poi la questione non può diventare “sì ma io dello Stato non mi fido”, la corruzione si combatte, e in questo è necessario il controllo del cittadino sull’operato dello Stato”.
Seguendo proprio l’accurata analisi di Saetta, quando parliamo delle scelte fatte in Oriente non vogliamo in alcuna maniera alimentare il mito dei paesi esteri che sono più bravi dell’Italia a gestire la crisi. Non si tratta affatto di questo: si tratta di rintracciare nei diversi sistemi culturali di attribuzione di senso dei percorsi di decisione politica. Lo stesso Saetta si premura di sottolineare la diversissima sensibilità sociale che sta dietro alle pratiche – politiche, civili, digitali – dei diversi paesi: egli descrive benissimo come le tanto elogiate strategie di Singapore provengano non da un modello tecnologico per se, ma da una consolidata infrastruttura sociale che si basa sulla trasparenza; da una tradizione di cooperazione tra stato e cittadini, che non si fonda su soluzioni tecnologiche ma su strategie sanitarie a lungo termine: “E, come sta accadendo troppo spesso negli ultimi anni, la soluzione la si vuole individuare nella tecnologia: una App che ci salverà dal coronavirus, perché gli italiani sono indisciplinati e incapaci di rispettare le regole (nonostante dai dati del Ministero degli Interni risultino sanzioni a poco più del 4% della popolazione). Una App, si dice, così come hanno fatto in Corea, a Singapore, come vogliono fare in Israele. Ma non è così, la soluzione miracolosa e veloce che ci salva dal virus non esiste, tutti i paesi citati si sono basati sulla pianificazione a lungo termine e su massicci investimenti nella sanità e nelle nuove tecnologie applicate alla sanità (es. telemedicina, diagnostica assistita da AI, stampa 3D, ecc…). L’utilizzo di strumenti di tracciamento della popolazione è solo l’ultimo pezzo di una catena sanitaria efficiente.”
È per questo che non ci auguriamo che venga messo in pratica quello che Evgeny Morozov chiama soluzionismo: non abbiamo bisogno di soluzioni tecnologiche ai problemi sociali, ma di un uso sociale delle tecnologie. Non soluzioni tecniche quindi, ma strategie sociali. Quando sosteniamo la necessità di un passaggio da vecchi sistemi produttivi ai nuovi, pensiamo alla possibilità di costruire un sistema che investa su queste necessità. Un sistema che deve mettere al centro lo stato sociale, le politiche di welfare. Non dovremmo trovarci costretti a scegliere tra la protezione dei nostri dati personali e il nostro diritto alla salute. Citiamo in questo senso Morozov – il cui contributo in francese potete trovarlo al link di cui sopra, mentre la traduzione in italiano la potete trovare sul numero 1352 di Internazionale: “Perché serve un compromesso tra privacy e salute pubblica? Forse perché le infrastrutture digitali di cui disponiamo sono costruite da aziende tecnologiche per favorire i loro affari? Sono state progettate per identificarci e fare di noi micro bersagli di interesse commerciale. Poca riflessione è stata dedicata alla costruzione di infrastrutture digitali che proteggano la privacy. Perché?”
A questo punto ci si potrebbe chiedere: perché dovremmo fidarci di un sistema pubblico che mette i nostri dati personali alla mercé di un errore di sistema, al quale viene poi attribuita la vecchia storiella dell’attacco hacker? Come dice Massimo Mantellini sul Post: “Servono i dati e servono le persone. Servono dati certi, che già l’epidemia è complicatissima e orientarsi è difficile per chiunque: servono persone umili e di buona volontà, innamorate delle cose fatte bene. Servono (servirebbero, per questa volta ormai è tardi) siti web di interesse pubblico che non siano rimasti a vent’anni fa per le solite ragioni che sappiamo, e persone che li sappiano far crescere e funzionare, specie quando in ballo ci sono milioni di italiani in comprensibile angoscia per il loro stipendio vaporizzato.” Abbiamo bisogno di leggere e interpretare il mondo. Abbiamo bisogno di trasformare le informazioni in dati. Abbiamo gli strumenti per farlo. E allora cosa manca?
Per arrivarci, manca ancora un tassello del ragionamento. Raccogliamo perciò la provocazione di Vincenzo Estremo su che fare: “la domanda che mi faccio e che ripropongo a chi mi legge è: per quale motivo allo stato delle cose ogni cittadino si sente tranquillo nel condividere i propri spostamenti mediante una semplice app che aiuta a ottimizzare le prestazioni dei runner, ma allo stesso tempo vede minacciata la propria libertà se gli viene chiesto di condividere anonimamente i propri spostamenti e i propri incontri a fini sanitari? Per quale motivo abbiamo accettato di fatto una cyber-biopolitica o una biopolitica del digitale impostaci surrettiziamente nelle condizioni d’uso dei social media, o dalle sue logiche di intrattenimento e gaming, ma invece non accettiamo che quegli stessi dati possano essere condivisi per fini di contenimento sanitario? Perché non avviamo una discussione sull’etica dell’uso collettivo dei dati e delle informazioni che inevitabilmente produciamo quotidianamente? […] Le risposte sembrano non poter arrivare, se di fronte a nuovi problemi ci ostiniamo ad adoperare vecchi strumenti e se continuiamo ad accettare che questioni collettive, quali quella dei big data, restino nella disposizione esclusiva di media-corporation.”
Quello che manca è una riflessione pubblica, condivisa e democratica sull’utilizzo dei dati. Il contributo di Saetta e di Estremo ci permettono di capire che i risultati che derivano dalle soluzioni di Singapore e della Corea del Nord non risiedono semplicemente nella tecnica. Ma in ciò che quella tecnica significa. La tecnologia non è altro che “society made durable”.
È ovvio che in una cultura nella quale non siamo abituate e abituati a chiederci “dove finiscono i miei dati?” e in cui legittimiamo silenziosamente il passaggio di queste informazioni preziosissime a terzi – i quali li usano senza vergogna per fare profitto – la prima soluzione che ci viene in mente è di delegare agli stessi il trattamento dei suddetti dati. Dopotutto, ci viene da pensare loro lo sanno fare. Hanno i mezzi – tecnologici – che evidentemente l’INPS non ha.
Fermiamoci però un secondo a riflettere. Perché l’INPS non ha i mezzi – e non solo tecnologici, ma infrastrutturali – per affrontare queste situazioni di crisi?
3) A chi appartengono i dati?
Il problema, facendo un giro non troppo distante dalle riflessioni sulla politica economica, continua a essere quello della proprietà. Come infatti sostiene la professoressa di diritto costituzionale Giovanna De Minico su MicroMega, non possiamo immaginare all’interno del contesto europeo una delega ai privati. Questo causerebbe una serie di problemi al legislatore, che deve garantire la tutela dei cittadini. “Il server dove confluiscono i dati nostri, deve essere di proprietà del nostro Stato. Qui si chiedono due attributi: pubblicità e nazionalità. Diversamente, in caso di suo affidamento alla mano privata niente ci assicurerebbe che questa tracciatura non fosse utilizzata come merce di scambio contro denaro in una trattativa con i Google di turno, avidi di dati per alimentari i loro affari data driven. Se così fosse, avremmo rinunciato alle nostre libertà per assecondare i piani lucrativi dei Giganti della rete. […] Le soluzioni tecniche non sono mai neutre: perché se procurano vantaggi a tutti o privilegi a pochi, dipende esclusivamente da come la mano pubblica le abbia orientate.”
Prima che la lettrice o il lettore si infurino paragonando queste soluzioni a quelle dei regimi totalitari, ricordiamo il punto di partenza della nostra riflessione: ogni strategia dipende dal contesto sociale in cui è inserita. La nostra riflessione non mira a inneggiare sterilmente a modelli di paesi esteri. Quello che vogliamo fare è dare il nostro piccolo contributo nell’allargare quello che sentiamo necessario: una riflessione condivisa e partecipata sul rapporto tra i nostri dati, le tecnologie che li raccolgono e trattano, e le politiche che li regolano.
Secondo Yuval Nuval Harari la questione di proprietà e gestione delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti che fanno parte del sistema di gestione della crisi, dà luogo a due potenziali scelte. Immaginiamole come due poli: da un lato troviamo la gestione della politica interna attraverso una sorveglianza totalitaria e delle relazioni internazionali attraversol’isolamento nazionalista ; all’estremo opposto invece troviamo rispettivamente la responsabilizzazione dei cittadini e la solidarietà globale. Harari descrive le scelte di stati come Corea del Sud, Taiwan e Singapore come casi in cui le politiche interne hanno permesso usi e sviluppi socialmente consapevoli della tecnologia. Questi si fondano su uno specifico rapporto tra cittadini e istituzioni, il quale viene descritto come “honest reporting, and on the willing co-operation of a well-informed public”. Non si tratta di come noi, dal nostro punto di vista, percepiamo le loro politiche, ma di come questi paesi abbiano dato forma ai rapporti sociali, permettendo la cooperazione tra diverse sfere della vita pubblica.
Ciò che invece emerge dalla sua analisi rispetto alla gran parte delle società occidentali è che “One of the problems we face in working out where we stand on surveillance is that none of us know exactly how we are being surveilled, and what the coming years might bring. Surveillance technology is developing at breakneck speed, and what seemed science-fiction 10 years ago is today old news. As a thought experiment, consider a hypothetical government that demands that every citizen wears a biometric bracelet that monitors body temperature and heart-rate 24 hours a day. The resulting data is hoarded and analysed by government algorithms. The algorithms will know that you are sick even before you know it, and they will also know where you have been, and who you have met. The chains of infection could be drastically shortened, and even cut altogether. Such a system could arguably stop the epidemic in its tracks within days. Sounds wonderful, right? The downside is, of course, that this would give legitimacy to a terrifying new surveillance system. If you know, for example, that I clicked on a Fox News link rather than a CNN link, that can teach you something about my political views and perhaps even my personality. But if you can monitor what happens to my body temperature, blood pressure and heart-rate as I watch the video clip, you can learn what makes me laugh, what makes me cry, and what makes me really, really angry.” E, precisa inoltre poco dopo, mettere in atto politiche di sorveglianza digitale come misure temporanee dovute ad uno “stato di emergenza” finisce spesso per farle sopravvivere anche oltre una dichiarata fine dell’emergenza.
Ovviamente la posizione sulla responsabilizzazione dei cittadini di Harari rischia di trascurare alcuni problemi: chi è il cittadino cui viene dato il potere? Come si situa nella società? Se l’attività del singolo viene posta come alternativa all’accentramento totalitario dei poteri di sorveglianza, risolve il problema del contratto sociale alla base della condivisione dei dati? Evgeny Morozov ci mette in guardia dal concetto di Citizen Empowerment: “Nell’idea dei soluzionisti è più o meno tutto quello che serve, perché i corpi e le istituzioni intermedie scompaiono. […] esistono cittadini-consumatori, aziende e governi. In mezzo non c’è molto altro: né sindacati né associazioni di cittadini né movimenti sociali né istituzioni collettive tenute insieme da sentimenti di solidarietà […] Le infrastrutture di cui disponiamo sono, è triste dirlo, infrastrutture di consumo individualizzato, non di solidarietà e assistenza reciproca. Come ogni piattaforma digitale, possono essere usate per vari scopi, tra i quali attivismo, difesa dei diritti e collaborazione, ma simili usi solitamente implicano un costo elevato e spesso invisibile. Costituiscono delle fondamenta molto fragili per un ordine sociale non liberista e post-soluzionista, che dovrà essere sempre popolato da attori che non siano consumatori, startup e imprenditori. L’idea di costruire questo nuovo ordine sulle fondamenta digitali offerte da Amazon, Facebook o dall’operatore di telefonia mobile del vostro paese può sembrare allettante, ma non ne verrà niente di buono. Sarà, nel migliore dei casi, l’ennesimo parco giochi per soluzionisti. Nel peggiore, una società totalitaria fondata su controllo e sorveglianza diffusi”.
4) Dalla disciplina alla responsabilità
Parlare di informazioni personali, della nostra delega ad organizzazioni sovra-individuali di informazioni sui nostri corpi e sulle pratiche ad essi connesse fa riecheggiare definizioni filosofiche, forse troppo spesso abusate.
A tal proposito, un altro dibattito importante correlato alla crisi del Coronavirus è stato quello che si è acceso nel campo filosofico, a partire da alcune problematiche affermazioni di Giorgio Agamben, che sono state o meno condivise in maniera diversa dalla critica. Non vogliamo soffermarci sull’argomento, ma approfittare delle riflessioni che fa il filosofo greco Sotiris sul blog Lasting Future sulla possibilità di una biopolitica democratica. Questa deve emergere dal basso: il cambio di prospettiva ci permette di considerare delle scelte che spostino dalla disciplina alla responsabilità. Se noi deleghiamo il controllo dei nostri dati a un’entità esterna, stiamo cedendo anche i nostri diritti. Dobbiamo invece, sviluppare una consapevolezza e una responsabilità rispetto ai nostri dati. Pensarci come una collettività ci permette di immaginare un modello organizzativo che non faccia di controllo, disciplina e sorveglianza i suoi concetti centrali: non abbiamo bisogno di un organo centrale che controlli i movimenti del collettivo. Abbiamo bisogno di stimolare la solidarietà fra le diverse aree del sociale.
Quando andiamo in ospedale, ci fidiamo che il nostro corpo, la nostra stessa vita sia nelle mani di un’istituzione pubblica. Perché non riusciamo a fidarci delle istituzioni? Riecheggiano le parole della professoressa Mazzocco, sul fatto che la scarsa efficienza delle infrastrutture pubbliche del nostro paese derivi da un lungo processo di deterioramento, dovuto alla continua sottrazione di investimenti e assenza di incentivi.
Riportiamo l’intervista di Francesca Bria su Repubblica la quale mette in luce come: “né l’approccio autoritario dall’alto verso il basso né l’approccio americano guidato dai Big Tech sono completamente compatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali che sono al centro del progetto europeo. L’Europa deve cogliere questo momento e dimostrare che si può essere innovativi e allo stesso tempo introdurre importanti tecnologie da cui dipende il futuro della nostra società ed economia; ora è il momento di dimostrare che possiamo farlo diversamente”. La ricercatrice è stata appena selezionata per far parte del gruppo di 74 esperti incaricati dal Ministero dell’Innovazione di interrogarsi sull’utilizzo dei dati per contenere la diffusione del virus in Italia; è inoltre presidentessa del nuovo Fondo Innovazione del gruppo Cdp. Come racconta facendo riferimento alla sua esperienza alla guida delle strategie politiche per l’innovazione del comune di Barcellona, “la capacità di usare dati e tecniche di intelligenza artificiale per migliorare i servizi pubblici può dare risultati meravigliosi […], in generale, abbiamo bisogno di maggiori investimenti in infrastrutture sicure per un utilizzo di dati anonimi”.
Abbiamo bisogno di politiche decisionali incentrate sulle persone e l’interesse collettivo: stiamo parlando di modelli inclusivi che riguardano una crisi che non è solo sanitaria, ma soprattutto sociale. “Molte decisioni data driven sul traffico, la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, — per non parlare dell’attuale ondata di applicazioni digitali nel campo della medicina e dell’educazione online — si possono prendere utilizzando i dati nel totale rispetto della privacy. Abbiamo anche tecnologie emergenti decentralizzate come la blockchain e protocolli cryptografici in cui l’Europa eccelle, che permettono di coniugare innovazione e sovranità sui dati per i cittadini”. Le alternative sono là fuori. Ma per trovarle c’è bisogno di mettere al centro la collettività.
5) Dalla responsabilità alla solidarietà
Dobbiamo quindi allontanarci da un discorso concentrato sulla sorveglianza e sulla sanzione, ma immaginare politiche basate su collaborazione e cooperazione. E questo non riguarda solo il dibattito sul rapporto tra dati, tecnologie, privacy e sanità, ma la politica tutta.
Per abbandonare il soluzionismo, dobbiamo superare il concetto di “emergenza”. Il collegamento che vi proponiamo a questo proposito è con la riflessione che Matteo Pascoletti fa su Valigia Blu sul perché dovremmo abbandonare il lessico bellico. Solo così possiamo mettere in pratica una sempre più necessaria solidarietà: “Ma proprio perché la pandemia rende più evidente che «ci sono sulla terra flagelli e vittime», come scriveva Albert Camus ne La peste, «bisogna per quanto è possibile rifiutarsi di essere col flagello», bisogna «non consentire all’assassinio», e riscoprire in noi lo spirito da veri medici, il concetto di cura in ogni gesto. Ed è per questo che dobbiamo abbandonare l’idea che quella al coronavirus sia una guerra, qualcosa basato su impeto, forza, produzione e dispiegamento di mezzi tesi ad annientare. Un virus, come nemico, non concede l’onore delle armi, né si siederà mai a un tavolo per trattare. Fuori da qualunque metafora, medici e infermieri hanno il diritto di lavorare in condizioni di sicurezza, senza dover diventare eroi. Bisogna piuttosto iniziare a ripensare radicalmente i rapporti – sociali, lavorativi, economici, politici – e capire, una buona volta per tutte, che non sarà il thatcheriano «Non esiste una cosa chiamata società» a salvarci. Proprio ora che il virus ci impone distanza, rapporti mediati dobbiamo riscoprire il concetto di società e, soprattutto, i valori sui cui la si vuole fondare. Se produrre significa esporre al contagio, allora c’è bisogno di ripensare il lavoro, persino superarlo. Se il lavoro permette di sopravvivere attraverso il salario, allora c’è da superare il concetto di salario. Ma se invece, come collettività, in un momento così critico, riusciamo a vederci solo come esercito, come reparti che devono obbedire a una catena di comando e come alleanze militari dal punto di vista sovranazionale, allora conosceremo la sconfitta, e sarà paragonabile a un gigantesco cane che si divora a partire dalla coda.”
Concordiamo infatti che la visione emergenziale sia la causa di molteplici problematiche: come ad esempio la pratica degli “sbirri da bacone”, che contribuisce a costruire un allarmismo inutile e, se mai, potenzialmente dannoso (così come illustrano i succitati articoli di Saetta e Pascoletti su Valigia Blu). Perché immaginare applicazioni tecnologiche sul controllo degli spostamenti dei cittadini, quando i risultati migliori si sono incontrati dove si è investito sulle applicazioni in campo medico?
Anche se possiamo condividere l’abbandono del lessico di guerra per quanto riguarda il trasformare i nostri nemici in vicini, o legittimare azioni altrimenti inaccettabili per “estrema necessità” o “emergenza”, ci ritroviamo costrett* a concludere con un ultimo punto. Non viviamo in un mondo dato, stabile. Concetti come proprietà, controllo e delega dipendono da una serie di rapporti di forza. Come ogni dato, sono il risultato di una costruzione.
Non possiamo quindi separare la solidarietà dal conflitto: non nel senso di violenza, di guerra, e di tutte le conseguenze discorsive di cui ci ha parlato Pascoletti. Conflitto nel suo senso sociale: quello stesso conflitto sociale che piattaforme e capitalismo contribuiscono sistematicamente ad oscurare. Quello stesso conflitto che ci porta a richiedere solidarietà, e non controllo. Quando parliamo di esigere dei cambiamenti, dobbiamo lottare per averli: non possiamo pretendere un cambiamento se non siamo in grado di mettere in discussione i concetti stessi di proprietà e democrazia. Solo così possiamo immaginare, oltre ogni soluzionismo, delle tecnologie solidali.
Come al solito, il problema non è tecnico o naturale: non siamo in guerra contro un virus, così come non ci aspettiamo risposte dalla tecnologia. Quello che facciamo è però lottare, per pretendere un mondo più giusto; lo facciamo pretendendo tecnologie che siano open, accessibili e solidali: tecnologie che tutelino tutti i nostri diritti. Nessuno escluso.
In un'industria che si basa sulle apparenze e sulle illusioni più fantasiose, c'è davvero da meravigliarsi che ci siano così
Non se lo ricorda quasi più nessuno, dopotutto siamo o non siamo nella terra della memoria dei pesci rossi? (sebbene
L’ultimo film di Paolo Sorrentino è tutto quello che non fu all’epoca La Grande Bellezza (2013). Dove nel film romano
Indirizzare gli itinerari terapeutici verso cure primarie territoriali dovrebbe essere, oggi più che mai, una priorità nelle agende della gestione
In tutto il mondo, già da diversi giorni, milioni di persone si affannano nell’acquisto di qualunque cosa si possa acquistare.
Sabato 12 giugno | ore 17 | Parco della Montagnola, Bologna Decolonizzare le menti per una psichiatria della Palestina colonizzata: